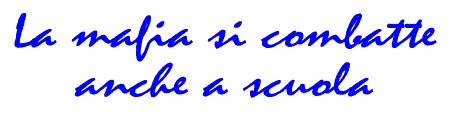|
|
||
|
|
||
|
Che
ruolo può avere nella lotta contro la criminalità organizzata, accanto
alle recenti innovazioni normative e al contrasto investigativo e
giudiziario, quello che noi chiamiamo l’approccio educativo? Penso
che l’approccio educativo sia fondamentale soprattutto nella
prevenzione della criminalità perché è proprio nell’approccio
educativo che il giovane deve acquisire quello che normalmente viene
chiamato il sentimento della legalità. Perché nella scuola si verifica
il primo momento in cui un giovane può entrare e spesso entra in
contatto con diversi da lui, diversi per condizione economica, capacità
intellettuali, lingua, razza. Proprio in queste diversità il giovane può
acquisire due doti fondamentali che sono anche alla radice di una norma
della nostra costituzione. Il concetto di eguaglianza fra tutti, che
vuol dire tolleranza, accettazione, comprensione del diverso, non
discriminazione fra sé e gli altri. Il secondo punto è la solidarietà
e cioè un intervento di aiuto perché coloro che si trovano in
condizioni differenziate e deteriori possano anche loro sviluppare la
loro personalità. Il nostro sistema costituzionale si fonda
sull’affermazione della dignità e
sulla valorizzazione della persona, sull’offrire a ogni
soggetto la
capacità di esprimere al massimo le sue potenzialità.
Ovviamente questo non si realizza solo nella scuola, però
penso che se un giovane nella scuola acquisisce questi due
capisaldi, cioè il rispetto delle diversità deficitarie nei suoi
confronti e la capacità di aiuto e di solidarietà,
questo costituisce una base fondamentale anche per la prevenzione
della criminalità. Inoltre le scuole sono un tessuto di immunizzazione
possibile dai pericoli delle devianze e dell’illegalità, quindi è
come dire una rete, che se si ispira a questi principi dà luogo a un
sentimento di legalità che funge da vaccino per comportamenti illegali,
per i silenzi di fronte alle illegalità. Deve suscitare una capacità
di reazione positiva, di denuncia. Perché il silenzio è la prima fase
del distacco dalle istituzioni, che poi in certe regioni dà luogo al
fenomeno tremendo dell’omertà. Come si può affrontare il problema psicologico e culturale della mentalità mafiosa, da cui discende l’omertà? Che cosa si può dire in materia ai ragazzi? Ai
ragazzi cercherei innanzi tutto di spiegare la realtà delle
organizzazioni mafiose, quindi sarebbe utile una breve cronistoria per
far capire che queste organizzazioni si sono radicate all’origine in
certe regioni, come la Sicilia (cosa nostra), la Calabria (n’drangheta),
la Puglia (sacra corona unita), la Campania (camorra) e come abbiano poi
avuto una capacità espansiva non solo nel territorio del nostro stato
ma anche all’estero. E soprattutto punterei sul fatto che queste sono
organizzazioni che gestiscono mercati illeciti, vale a dire la droga, il
contrabbando di tabacchi, le armi, il traffico delle persone umane, il
traffico di organi. Il mercato praticato da queste organizzazioni deve
suscitare distacco. Bisogna far capire che chi fuma uno spinello che gli
sembra una cosa innocua dà un contributo, sia pure piccolo ma che poi
si assomma ai contributi di milioni di persone, a rafforzare queste
organizzazioni. Le quali agiscono unicamente per fini di profitto
personale: ci sono dei guadagni enormi che non si traducono mai in
sviluppo ma in regressione della società. Tutti questi denari che loro
accumulano in parte poi li riversano nel gestire attività economiche
apparentemente lecite che comprimono l’economia legale. Per
raggiungere questi fini non esitano poi a dare morte: questo è un altro
punto fondamentale, e la figura del mafioso va in un certo senso
smitizzata. Il delinquente ha sul giovane una forte attrattiva di eroe
negativo, grazie alle trasmissioni, ai film. Bisogna far capire che la
vita di queste persone, a differenza da quanto loro dicono, è una vita
disperata perché è percorsa sempre nel tentativo di sottrarsi alla
morte che gruppi criminali a loro contrapposti cercano di dare per avere
maggior potenza. Recentemente
abbiamo invitato Mario Caniglia a parlare agli alunni di terza media di
Arezzo. Erano quattrocento, pendevano letteralmente dalle sue labbra e
alla fine lo hanno tempestato di domande. Come si può capitalizzare
questa esperienza? Innanzi
tutto invitando i ragazzi a effettuare delle riflessioni, riflessioni
scritte, anche di poche righe. Invitarli a una riflessione personale per
vedere poi di combinarle insieme, perché può darsi che siano diverse,
viste da prospettive diverse, e anche perché il ritornarci, il
meditarci sopra, fa riaffiorare quegli stimoli che li hanno mossi a fare
domande. Quando uno fa una domanda manifesta un interesse. Possiamo dire, pensando a Martin Luther King (I have e dream…) che sconfiggere la mafia è un sogno ma non un’utopia? Che il sogno si può realizzare? Io non userei né la parola sogno né la parola utopia. Io penso sempre che alle radici dei grandi obiettivi ci debba essere sempre un sogno o un’utopia. In che senso? Nel senso di vedere una cosa diversa da quella che la realtà ci pone e quindi di immaginare traguardi oltre l’orizzonte piatto nel quale spesso viviamo. Ma questo è inutile se non si traduce in impegno. L’utopia è per così dire un sogno, sia pure positivo, vedere un qualcosa di buono che si può raggiungere: è lo stimolo che deve far scattare l’impegno. Perché la convinzione è che queste battaglie non sono solo delegabili agli altri, in particolare agli organi dello stato, alle istituzioni: se non ci si muove in una sintonia tra la società e queste istituzioni che spesso tendono a restare lontane, il discorso è finito. Ecco perché siamo partiti dall’esperienza scolastica come esperienza positiva: proprio perché dà questo senso dell’impegno.
|
||